Quando le istituzioni smettono di funzionare
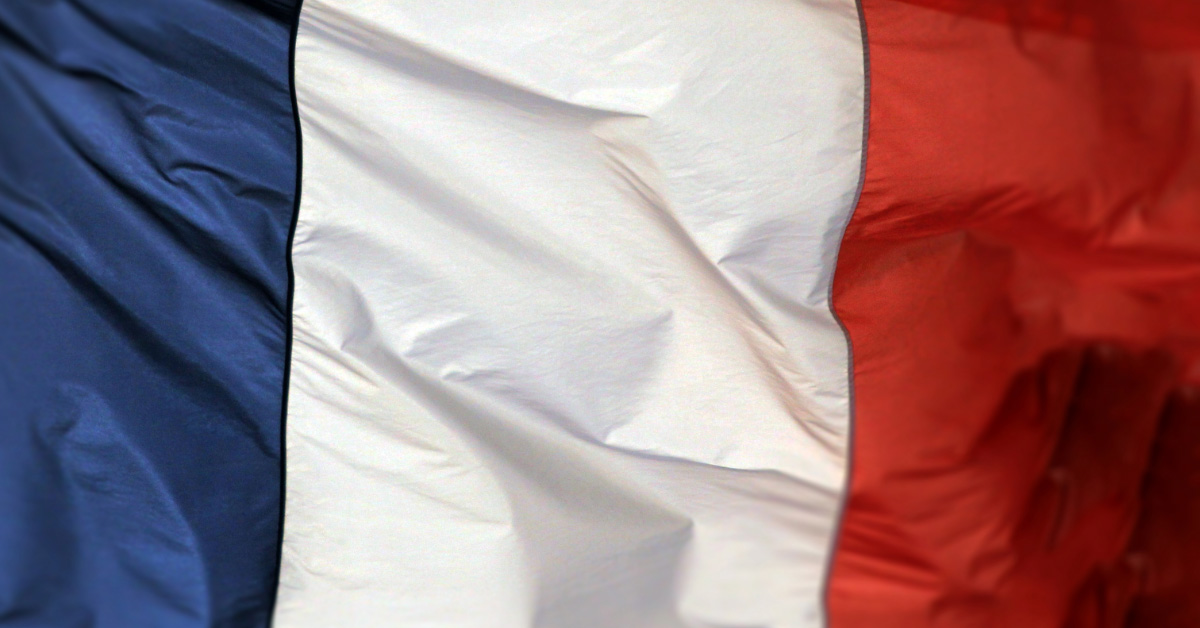
La Francia sta vivendo la sua quinta crisi di governo in meno di due anni. Sébastien Lecornu, appena nominato primo ministro, guida un esecutivo che è sostanzialmente identico a quello di François Bayrou, caduto dopo appena tre mesi. Stessi ministri, stessa maggioranza fragile, stessa missione impossibile: approvare un bilancio che richiede tagli per 44 miliardi quando il parlamento è controllato da opposizioni che hanno costruito il loro consenso proprio promettendo di non tagliare nulla.
Sembra l'ennesima soap opera politica europea. Ma se sai guardare oltre la cronaca, quello che sta succedendo in Francia è un caso da manuale di cosa accade quando l'architettura istituzionale di un sistema entra in conflitto irreversibile con la realtà politica che dovrebbe governare. Ed è un pattern che non riguarda solo Parigi - lo vedrai ripetersi, con variazioni locali, in tutte le democrazie occidentali che non hanno ancora capito che il mondo per cui erano state progettate non esiste più.
Il problema è architetturale, non politico
La Quinta Repubblica francese fu progettata da Charles de Gaulle nel 1958 con un obiettivo chiarissimo: mettere fine all'instabilità cronica della Quarta Repubblica, dove governi fragili cadevano ogni pochi mesi perché nessuno aveva mai una maggioranza solida. La soluzione? Un presidente forte, eletto direttamente, con poteri di nomina e di scioglimento del parlamento. Un sistema fatto per garantire che ci fosse sempre un vincitore chiaro, una maggioranza che governasse, quello che i francesi chiamano il "fatto maggioritario".
Tutto il design istituzionale parte da questo assunto: il sistema è bipolare. Centro-destra contro centro-sinistra, con variazioni sul tema, ma sempre due blocchi che si alternano. In questo contesto, strumenti come l'articolo 49.3 della Costituzione - che permette al governo di far passare una legge senza voto a meno che non venga sfiduciato - funzionano magnificamente. Sono deterrenti credibili. "Volete bloccare questa legge? Benissimo, ma allora dovete avere il coraggio e i numeri per far cadere il governo". E siccome nessuno li aveva mai davvero, il meccanismo garantiva stabilità .
Ma oggi? La Francia ha tre blocchi di dimensioni quasi uguali che si odiano reciprocamente. Il Nuovo Fronte Popolare (sinistra radicale) con 178 seggi, Ensemble (il centro macronista) con 150, e il Rassemblement National (destra radicale) con 142. Nessuno può governare da solo. Ma tutti possono impedire agli altri di farlo.
È quello che il documento che ho analizzato chiama perfettamente la "maggioranza negativa": non esiste una maggioranza per costruire nulla, ma esiste sempre una maggioranza per distruggere. L'architettura istituzionale continua a cercare disperatamente quel vincitore chiaro che non esiste più, mentre la realtà politica ha prodotto un equilibrio tripolare stabile. Risultato: paralisi sistemica.
Quando la medicina diventa il veleno
L'articolo 49.3 è un caso affascinante di come uno strumento progettato per risolvere un problema finisca per aggravarlo quando il contesto cambia. Élisabeth Borne, primo ministro prima di Bayrou, lo ha usato 23 volte nel suo mandato. È diventato routine, l'unico modo per far passare qualsiasi cosa in un parlamento frammentato.
Ma c'è un effetto collaterale che nessuno aveva previsto: normalizzando l'uso del 49.3, hai desensibilizzato le opposizioni alla minaccia della sfiducia. La prima volta che lo usi, è un bluff credibile. "Attento, se voti contro, cade il governo e si va a nuove elezioni - vuoi davvero correre questo rischio?" Ma se lo usi ogni mese, non è più un bluff. È solo il modo normale di fare le cose. E allora le opposizioni, invece di essere intimidite, iniziano a organizzarsi.
Michel Barnier, predecessore di Bayrou, è caduto proprio così. Ha usato il 49.3 sul bilancio della Sicurezza Sociale, e per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, le opposizioni hanno avuto i numeri per sfiduciarlo davvero. 364 voti contrari. Un evento storico che ha dimostrato due cose: primo, che la "maggioranza negativa" esiste ed è operativa. Secondo, che lo strumento pensato per proteggere il governo è diventato il detonatore che lo fa saltare.
Sébastien Lecornu ha imparato la lezione e ha promesso di non usare il 49.3. Il che significa che ora deve mendicare voti in un'Assemblea Nazionale dove tre deputati su quattro vorrebbero vederlo cadere. È disarmato prima ancora di iniziare.
La game theory dell'ostruzionismo
Ora, la domanda interessante: perché le opposizioni si comportano così? Perché La France Insoumise e il Rassemblement National, che ideologicamente sono agli antipodi, votano insieme per far cadere ogni governo che Macron propone?
La risposta sta nella game theory pura. Se sei un leader di opposizione radicale - Jean-Luc Mélenchon a sinistra, Jordan Bardella a destra - quale strategia massimizza il tuo payoff per le elezioni presidenziali del 2027?
Opzione A: Collabori con Macron. Negozi, fai compromessi, permetti al governo di governare. Rischio: i tuoi elettori ti vedono come complice del sistema che odiano. Perdi credibilità , il tuo blocco si frantuma, alle presidenziali arrivi indebolito.
Opzione B: Fai ostruzionismo totale. Fai cadere ogni governo. Dimostri che il "centro" è impotente, che non può governare, che il macronismo è finito. Ti presenti come l'unica alternativa vera, quella che non ha compromesso i suoi principi. Risultato: massimizzi il tuo capitale politico per il 2027.
La scelta è ovvia. L'ostruzionismo non è infantile o irresponsabile - è perfettamente razionale dato il sistema di incentivi. Il problema non è che i politici sono cattivi o immaturi. Il problema è che le regole del gioco producono questo comportamento come equilibrio dominante.
E c'è un altro livello: la politica francese, come quella di tutte le democrazie occidentali contemporanee, è sempre più una questione di performance identitaria anziché di negoziazione di interessi. I tre blocchi non sono solo posizioni politiche diverse - sono tribù che hanno costruito la loro identità in opposizione reciproca. Ogni compromesso non è visto come pragmatismo, ma come tradimento. Quando questo succede, i sistemi pensati per il compromesso vanno in tilt.
Les Républicains e il nodo che non tiene
C'è un attore che merita attenzione particolare: Les Républicains, l'ex partito gollista ridotto a 39 deputati ma paradossalmente cruciale. Loro sono troppo pochi per governare da soli, troppo diversi ideologicamente dal macronismo per sentirsi a casa, ma terrorizzati dall'idea di andare all'opposizione perché il Rassemblement National gli mangerebbe tutto lo spazio elettorale.
Risultato? Metà di loro sta nel governo (il ministro dell'Interno Bruno Retailleau, la ministra della Cultura Rachida Dati, altri), l'altra metà vota con le opposizioni per far cadere il governo. È quella che il documento sulla crisi francese definisce perfettamente una "coabitazione interna". Un partito che non sa più chi è.
Dal punto di vista della network architecture, Les Républicains occupa un structural hole - fa da ponte tra il centro e la destra. In teoria, questa è una posizione di enorme potere. Chi controlla un ponte controlla il flusso. Ma in pratica, li sta lacerando. Perché quando un nodo di rete non decide quale identità mantenere, perde tutta la sua utilità strategica. E rischia di implodere.
Se Les Républicains si frantuma - e ci sono tutti i segnali che potrebbe succedere - il governo Lecornu cade automaticamente. Senza quei 39 deputati, i numeri non tornano più. Ed è per questo che Lecornu è stato scelto: viene dalla destra, è un gollista, la sua missione principale non è governare, è tenere insieme Les Républicains abbastanza a lungo da sopravvivere al voto sul bilancio.
Il pattern universale
Ora, la parte che dovrebbe interessarti davvero: questo non è un problema francese. È il pattern che emerge quando istituzioni progettate per il bipolarismo incontrano la frammentazione multipolare del XXI secolo.
Lo vedi in Italia, dove governi di coalizione improbabili durano perché nessuno vuole andare a elezioni che potrebbero andare peggio. Lo vedi negli Stati Uniti, dove il Congresso è paralizzato e il governo federale rischia lo shutdown ogni anno perché i moderati sono scomparsi e i radicali di entrambi gli schieramenti preferiscono la guerra permanente al compromesso. Lo vedrai in Germania quando i Verdi, la SPD e i liberali non riusciranno più a stare insieme e dovranno decidere se allearsi con l'AfD o andare al voto.
Il pattern è sempre lo stesso:
- Istituzioni che assumono un sistema bipolare
- Realtà politica che produce frammentazione multipolare
- Incentivi elettorali che premiano l'ostruzionismo più della costruzione
- Identità tribali che sostituiscono le coalizioni pragmatiche
- Orizzonti temporali degli attori che si spostano dal presente (governare oggi) al futuro (vincere domani)
Quando tutti questi elementi si allineano, ottieni paralisi. E la paralisi si auto-rinforza, perché ogni crisi di governo indebolisce ulteriormente la fiducia nel sistema, radicalizza ulteriormente gli elettori, e rende ancora più costoso politicamente qualsiasi compromesso.
Cosa succederÃ
Lo scenario più probabile? La Francia tirerà a campare fino al 2027. Lecornu sopravviverà alcuni mesi, forse approvando un bilancio talmente annacquato da essere irrilevante, poi cadrà anche lui. Macron nominerà un altro primo ministro. Il ciclo si ripeterà . L'intera legislatura diventerà una lunghissima, caotica campagna elettorale per le presidenziali, con ogni voto in parlamento trasformato in un mini-referendum sulla futura presidenza.
Nessuna riforma strutturale verrà approvata. Il debito continuerà a crescere. I mercati inizieranno a preoccuparsi. E nel 2027 avremo probabilmente una presidenziale apocalittica tra estrema destra ed estrema sinistra, con il centro macronista che imploderà e sparirà .
Per risolvere davvero il problema servirebbe cambiare l'architettura istituzionale. Passare a un sistema parlamentare che costringa alla formazione di coalizioni prima del voto. Modificare la legge elettorale per incentivare le aggregazioni. Ricostruire una cultura politica del compromesso.
Ma nessuna di queste soluzioni è politicamente feasible perché richiederebbe che gli attori attuali rinuncino ai vantaggi del sistema disfunzionale. È il classico problema del secondo ordine: per risolvere la crisi servirebbe cooperazione, ma la crisi stessa distrugge ogni incentivo a cooperare.
Quindi assisteremo al collasso al rallentatore. Non perché i politici francesi sono stupidi o cattivi, ma perché il game design istituzionale produce inevitabilmente questo outcome. È il risultato di quarant'anni di erosione del centro, di polarizzazione ideologica, di frammentazione sociale che le istituzioni della Quinta Repubblica non erano state progettate per gestire.
Clinical realism, non cinismo. È solo vedere i pattern per quello che sono.
Iscriviti alla newsletter The Clinical Substrate
Ogni venerdì, pattern recognition attraverso i layer che altri non vedono.
